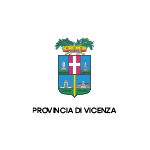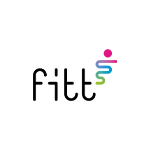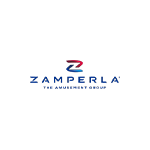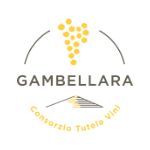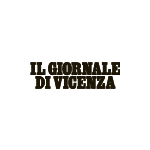Istituzioni italiane e americane, esponenti del mondo culturale, artistico, economico, esperti e professionisti di fama internazionale. Un’occasione speciale per incontrare ospiti d’eccezione come scrittori, registi, storici, artisti, chef stellati e figure influenti nella scena italo-americana.
Dylan Dog, figlio (italiano) della cultura postmoderna
Ascolta il podcast
Puntata a cura di Untimoteo.
Non è semplice spiegare per chi non ha vissuto gli anni ‘90 l’impatto cultural-popolare del fumetto Dylan Dog nelle menti dei lettori italiani. Un personaggio atipico (ma neppure troppo se guardiamo alla tradizione degli antieroi a fumetti del Belpaese). Vignette zeppe di immagini raccapriccianti, delitti efferati, mostri di ogni sorta – ma anche di momenti toccanti fin nel profondo. Narrazioni intrise di cultura classica messa a convivere con citazioni di film cult e della televisione. Il tutto mixato con un’apparente noncuranza da un padre sfuggente e geniale, uno dei più grandi maestri del fumetto italiano: Tiziano Sclavi.
Dylan Dog è figlio (italiano) della cultura postmoderna soprattutto di matrice anglosassone e americana. Rifiuta i grandi ideali in nome dell’ibridazione dei linguaggi e dei generi, si compone di frammenti, si trova a suo agio tra i messaggi ambigui e cerca rifugio nell’autoironia.
Dylan è un investigatore privato che sembra una mutuazione del più famoso detective della narrativa: Sherlock Holmes. Ma non ne è la versione attualizzata, ne è la negazione. Il personaggio di Sir Arthur Conan Doyle è il figlio del positivismo: il paladino del metodo deduttivo basato su osservazioni dettagliate, analisi logica e metodo scientifico. Dylan Dog va all’esatto opposto: è l’indagatore dell’incubo, il detective dell’irrazionale a cui ti rivolgi quando nessuno ti crede, quando quello che hai vissuto va oltre ogni razionalità conosciuta.