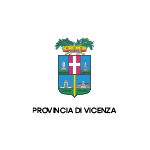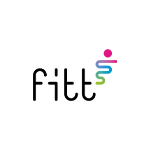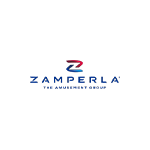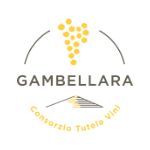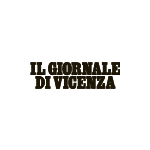Nell’attuale panorama delle grandi serie HBO, The White Lotus occupa un posto di rilievo assoluto: antologico, feroce, globale e, in particolare nel suo capitolo “italiano” su cui ci concentreremo qui, straordinariamente evocativo. Un’umanità opulenta e insicura in vacanza, in fuga dalla noia, dai sensi di colpa e da se stessa, osservata attraverso l’occhio affilato di Mike White.
Il cuore della nostra analisi sarà la stagione 2, con la sua potente rappresentazione della Sicilia, dell’italianità e del mito italoamericano – tra dolce vita e ombre profonde.
Quando HBO lancia The White Lotus nel 2021, nulla lascia immaginare che questa miniserie autoconclusiva diventerà uno dei prodotti più influenti e premiati (15 Emmy, 2 Golden Globes) della tv recente. Il successo è immediato: Mike White, già autore brillante e outsider del sistema, trasforma la storia di una settimana in un resort di lusso in una perfetta macchina narrativa per radiografare vizi e ipocrisie dell’Occidente. Ogni stagione – Hawaii, Sicilia, Thailandia – è insieme ritratto satirico e giallo balneare, con la suspense di una morte misteriosa e l’esplorazione chirurgica delle tensioni tra ospiti e personale.
L’antologia di White funziona perché capisce il nostro tempo: racconta i privilegi globali e il loro progressivo svuotamento, la crisi della ricchezza, le maschere e le ferite della società opulenta. E lo fa con uno stile inconfondibile: scrittura brillante, ritmo feroce, regia e musica che mescolano ironia, inquietudine e malinconia.
Le stagioni 1 e 3: cornice e trasformazione di una satira globale
La stagione d’esordio di The White Lotus mette in scena, alle Hawaii, l’inferno dietro la cartolina. L’élite americana in vacanza – tra ricchezza, ipocrisia e insoddisfazione – si confronta con lo staff del resort, altrettanto opportunista e disilluso. Il paradiso si fa trappola. Ogni puntata scava sotto la superficie dell’apparente perfezione e scopre un’umanità sgradevole, spaesata, costantemente in cerca di conferme e compensazioni.
Dopo la Sicilia del secondo capitolo, su cui torneremo meglio, la terza stagione porta la storia in Thailandia: qui, tra spiritualità orientale e ansie occidentali, la serie si fa ancora più cupa, lasciando emergere la fragilità di personaggi che consumano il sacro come l’ennesima esperienza da aggiungere al proprio ingordo curriculum emotivo.
In ogni stagione, la “vacanza” si rivela il dispositivo perfetto per svelare maschere e inganni: si ride, si soffre, si assiste all’autodistruzione di un’umanità che ha perso la bussola. Ma è la stagione italiana a dare alla serie il suo capitolo per noi più significativo.
L’Italia secondo The White Lotus: dolce vita e fantasmi a Taormina
Con la seconda stagione, The White Lotus arriva in Sicilia e si appropria – con maestria, ironia e grande capacità di citazione – dell’immaginario italiano filtrato dalla cultura di massa americana. L’Italia che vediamo a Taormina è la summa di sogni, stereotipi, omaggi cinefili e rimandi pop: dalle terrazze barocche ai vicoli assolati, dalle statue classiche ai costumi “alla Monica Vitti”, tutto richiama la dolce vita. L’avventura. La bellezza un po’ decadente.
Il resort, affacciato su un Mediterraneo sensuale e inquieto, è lo scenario ideale per un nuovo gruppo di turisti americani che inseguono, consapevolmente o meno, un’idea di felicità e trasgressione che ha radici profonde nell’immaginario italoamericano.
La protagonista Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge, sogna di attraversare Palermo in Vespa come una diva anni Sessanta. Tra scene da commedia sexy e momenti di autentica suspense, la stagione gioca con gli archetipi del cinema italiano. C’è Fellini, c’è Antonioni, c’è un certo giallo all’italiana che si mescola con atmosfere quasi hitchcockiane.
L’Italia di The White Lotus è un luogo di eccessi, sensualità, mistero e desiderio. Uno specchio in cui gli americani proiettano le loro fantasie di fuga e scoperta, ma anche le loro paure più profonde. Il Mediterraneo diventa così teatro di perdizione e rinascita, dove il confine tra realtà e sogno, innocenza e colpa, si fa sempre più labile.
La famiglia Di Grasso: radici, fantasmi e identità italoamericana
Tra i molti fili narrativi della stagione siciliana, quello della famiglia Di Grasso è centrale nella rappresentazione del rapporto tra Italia e America. Tre generazioni di maschi italoamericani – nonno, figlio e nipote – tornano in Sicilia sulle tracce delle proprie origini. In cerca di un legame autentico con la terra degli avi e forse anche di una riconciliazione personale.
F. Murray Abraham è un nonno nostalgico e affascinato dal mito della patria lontana. Michael Imperioli, già indimenticabile nei panni di Christopher ne I Soprano, altra serie centrale nella definizione dell’immaginario italo-americano nella cultura pop, interpreta il figlio Dominic, alle prese con i suoi demoni interiori, le dipendenze, i sensi di colpa per i rapporti falliti. Il giovane nipote (Adam DiMarco), invece, cerca nella Sicilia una radice da cui ripartire. Ma si scontra con la realtà di un’Italia che non esiste più, se non nella memoria o nella narrazione familiare.
Il viaggio dei Di Grasso mette in scena la frattura generazionale e il senso di spaesamento degli italoamericani tornati “a casa”, ma anche la difficoltà di trovare un’appartenenza reale. Le dinamiche tra questi uomini rievocano i temi classici della diaspora italiana: nostalgia, orgoglio, delusione e il desiderio – spesso frustrato – di sentirsi parte di una comunità che, di fatto, li guarda ancora come stranieri. La scelta di Imperioli nel cast, che richiama volutamente il suo passato televisivo legato all’immaginario mafioso, arricchisce ulteriormente il discorso sulla rappresentazione italoamericana nella cultura pop.
Non siamo più davanti ai gangster, ma a uomini fragili, insicuri, umani.
Tanya a Palermo: miti, travestimenti e ombre italiane
Il soggiorno di Tanya a Palermo è un vero omaggio – e una riflessione insieme ironica e tragica – sull’Italia e i suoi miti. La Coolidge, in abiti da diva, si muove tra ville, teatri e vicoli con una leggerezza solo apparente, mentre intorno a lei si addensano misteri e pericoli. Le sue avventure si tingono di giallo e commedia sexy, tra equivoci, seduzioni e una sequenza finale che la trasforma, suo malgrado, nell’eroina tragica di un film italiano d’altri tempi.
Questa storyline, che attraversa la stagione, è costruita come una danza tra omaggi e parodie. La Vespa, la citazione diretta a Monica Vitti, la presenza di personaggi ambigui e maschere carnevalesche, tutto richiama la tradizione cinematografica e letteraria del nostro Paese. Palermo diventa luogo simbolico: è teatro di incontri e scontri, di sensualità e minaccia, di libertà e condanna.
Attraverso Tanya, The White Lotus gioca con i sogni americani sull’Italia, ma mostra anche il rovescio della medaglia: la difficoltà di trovare davvero, in questa terra evocata e desiderata, la felicità e il senso di appartenenza che si cercavano.
L’Italia “da cartolina” di The White Lotus e la verità del presente
La forza della stagione italiana di The White Lotus è qui: riesce a evocare la magia del mito, della dolce vita, del Mediterraneo come promessa di piacere e riscatto, ma allo stesso tempo non nasconde le ombre di un Paese segnato dalla crisi, dalle contraddizioni, dai conflitti.
L’Italia di Taormina è una cartolina splendida e ingannevole: per gli americani in vacanza è teatro di libertà e trasgressione, ma anche specchio delle proprie inquietudini e delusioni. Gli italiani, nel racconto di Mike White, sono complici e antagonisti, seduttori e sfruttati, parte attiva e passiva della grande messa in scena del turismo globale.
Questo sguardo straniero, che osserva e giudica, non è mai del tutto innocente: la Sicilia è insieme sogno esotico e luogo di espiazione, paradiso e trappola. La musica, i paesaggi, i corpi, i dialoghi, ogni dettaglio contribuisce a costruire un’Italia viva e cinematograficamente vibrante. Ma anche profondamente malinconica.
La stagione 2 diventa così un laboratorio di rappresentazione: è il luogo dove si confrontano e si scontrano l’America che desidera, l’Italia che si offre (o si difende), il passato e il presente, la memoria e la disillusione.
Perché The White Lotus parla (anche) di noi
Tiriamo le somme. La seconda stagione di The White Lotus è molto più che un viaggio turistico nell’Italia da sogno: è un’indagine sulle radici culturali di due mondi che si attraggono e si fraintendono, che si specchiano l’uno nell’altro per capire – forse – qualcosa di più di sé. In ogni episodio, il rapporto tra italiani e americani viene scomposto e rimesso in scena. Tra equivoci, ironia, seduzione e spaesamento. Lasciando emergere verità scomode, ma anche un senso di complicità e fascinazione reciproca.
La serie di Mike White si conferma una delle narrazioni più potenti del nostro tempo, capace di utilizzare l’Italia come specchio (deformante, ma mai banale) delle inquietudini occidentali. La stagione siciliana resta un piccolo gioiello di scrittura e immaginario: una dichiarazione d’amore – e una richiesta di perdono – per quel mito italiano che, nonostante tutto, continua a esercitare il suo fascino irresistibile.
Nel contesto del Festival Italia-America, The White Lotus ci offre l’occasione di riflettere sulle dinamiche, le ossessioni e le speranze che ancora uniscono e dividono questi due mondi.
E sul modo in cui il racconto televisivo può, oggi come ieri, riscrivere la nostra idea di identità, di viaggio e di appartenenza.